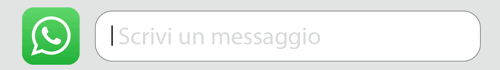Quell’uomo sono io! La malattia mi aveva portato all’estremo limite della vita, il corpo gonfio e scheletrito, gli occhi gialli, la coscienza confusa, le forze sparite ed il sonno, un sonno continuo che portava con se il desiderio di non esserci più.
Entrai in sala operatoria su una barella che andava lentamente tra corridoi e ascensori: era il mio tunnel nel quale si compiva il mio destino che non avevo l’energia per determinarlo, per stimolarlo, oppormi, crederci.
Poi il buio oltre la vita, in un silenzio profondo che portava un sonno imperioso. Da medico anzi da chirurgo questa storia l’avevo vista infinite volte: dall’altra parte. Questa volta toccava a me, con poche speranze di farcela.
La mia malattia era iniziata subdolamente oltre 20 anni prima: febbre ed ittero, la diagnosi fu di epatite virale. Mesi di riposo, alimentazione attenta, lunghi sonni, per la verità pochi farmaci. Forse la causa fu una contaminazione al tavolo operatorio operando un malato infetto. Forse fu altrove non sapendo dove. “Certo è che furono lunghi anni di attenzioni e preoccupazioni, controlli. Infine si presentarono i segni di una evoluzione non favorevole, così quell’inverno di molti anni dopo l’aggravamento fu evidente e si pose il problema del ricovero per il trapianto del fegato…
Quella malattia con cui aveva convissuto tutta la vita, come un compagno invadente, era stato un incubo con il quale lui medico, aveva dovuto fare i conti, immaginando la morte che ad un certo punto sarebbe venuta e che avrebbe voluto affrontare a casa come un ultimo sonno. Si era preparato, e il pensiero della fine scendeva su di lui come un balsamo, placava l’ansia e la disperazione che lo prendeva all’improvviso. Aveva fatto controlli in passato da epatologi di fama, poi esami, biopsie, radiologie. Si era trovato che il fegato era in buono stato, ma mostrava segni di possibili evoluzioni negative.
Una terapia specifica non esisteva.
Continuò a fare controlli, ma da ultimo aveva smesso, in una sorta di fatalismo che per altro era congeniale al suo carattere e in qualche modo legittimato dalla consapevolezza che non c’era terapia. Poi aveva cominciato a non stare più bene, il lieve sub-ittero delle sclere si era accentuato, l’addome era più voluminoso, un senso di affaticamento progressivo, un sonno micidiale anche durante il giorno. Per questo si era deciso a fare di nuovo controlli, per questo si trovava lì. L’ospedale era un brutto manufatto: il grigio anonimo del cemento con tratti di mattone chiaro, tentativi mal riusciti di abbellimento.
Era arrivato quel pomeriggio con Lisa, aveva parcheggiato la macchina in uno spazio oltre la strada che fungeva da parcheggio Lei aveva voluto accompagnarlo, nonostante lui avesse insistito che non c’era bisogno, che si trattava di sostenere solo degli esami, che sarebbe stato lì per pochi giorni. Niente, Lisa aveva preso dei giorni di ferie dal lavoro, e ora stava lì con lui in quella stanza troppo grande per entrambi. Stavano soli e in silenzio, non trovavano parole adatte ad alleggerire quel disagio, e quelle dette, suonavano false. Non appena sistemato, insistette perché lei tornasse a casa.
Il giorno dopo cominciò il viaggio. Il parlare sottovoce dei medici durante la visita mattutina, mentre guardavano la cartella dove erano riportati gli esami del giorno. Spiava sul loro volto espressioni che potessero rivelare qualcosa della malattia, del suo stato, magari del suo essere sano nonostante tutto. La sonda scivolava sulla pelle a scoprire la struttura del fegato, si fermava, tornava indietro per guardare meglio, forse aveva intravisto qualche degenerazione neoplastica…”non respiri, trattenga l’aria, respiri…”.
Non chiedeva , non aveva il coraggio ancora di sentirsi dire che la cosa era grave e nello stesso tempo sperava che avrebbe visto arrivare d’improvviso il Primario, quello che lo aveva ricoverato, che gli avrebbe detto di tornarsene a casa, al suo lavoro, perché si, c’era quella sofferenza epatica, di cui d’altra parte lui sapeva da anni, ma l’organo era ben compensato e dunque doveva continuare a fare una vita sana, e che si sarebbe dovuto ricontrollare più in là. Aveva deciso di aspettare a chiedere, di comportarsi come tutti i malati, di non profittare della sua condizione di medico, per un colloquio più facile con i curanti. Era anche paura di una sentenza sfavorevole, di darsi più tempo per prepararsi. Ma quella mattina della ecografia non resistette e chiese di sapere qualcosa. Lo chiese con una malcelata sicurezza, la voce però era un po’ rotta. Si qualificò come collega e attese la risposta. Il radiologo dette mostra di non essersi accorto dell’ansia che attanagliava chi gli stava dinanzi. Rispose che il flusso del sangue nella vena porta era rallentato, come quello nella vena splenica, che la milza era ingrandita, per il resto non si dilungava, perché lui in quanto medico conosceva certamente la situazione.
A lui il giorno successivo sarebbero toccati altri esami endoscopici e strumentali. Li fece.
Ancora qualcosa l’indomani e l’iter sarebbe stato completato. Quando tutto era compiuto, finita la visita del mattino chiese al Primario di poter parlare con lui. Pronunciò parole inciampando sul qualche consonante, per il resto cercando di assumere un atteggiamento virile e pronto. Le frasi di risposta furono gentili, professionali, un po’ distaccate: il fegato era compromesso, certo avrebbe potuto andare avanti, superare quel momento di aggravamento, ma tra qualche anno che sarebbe successo? Lui capì che quella sentenza non definitiva, quella proroga di un tempo indefinito prima che… era solo un dire cortese. Dunque rimase in silenzio, aspettando di ascoltare parole sospese che giravano nell’aria e che la conclusione delle precedenti aveva in qualche modo annunciato.
Queste arrivarono, attese dunque, anche se non domandate e che infatti non avrebbe voluto ascoltare: bisognava fare un trapianto.
Sentì il vuoto nella testa, non un dolore , né consapevolezza del significato delle parole, come un pugno sul ring che ti manda al tappeto per alcuni istanti e poi ti riprendi facendo finta che non é successo niente.Riprese la macchina parcheggiata per quei maledetti giorni davanti l’Ospedale e affogò nell’attenzione alla guida ed al traffico la disperazione dell’anima.
Era entrato nel tunnel che aveva deciso di percorrere, entrando in quel piccolo Ospedale, ora si trattava di affrontare la parte più difficile. Si prese una giornata che trascorse in giro per la città come un qualsiasi turista. Dormì incredibilmente , con un sonno profondo come grazia e conforto del Signore.
Dal lunedì successivo cominciò il nuovo e assolutamente più complesso iter: esami del sangue , endoscopie, radiologie , scintigrafie, risonanze magnetiche, Tac… C’erano vene dilatate nell’esofago e nel retto segni della difficoltà del sangue ad attraversare il fegato per arrivare al cuore.
Si potevano rompere per l’aumentata pressione e per la sottigliezza delle pareti. Si ricordò dei tanti malati che aveva assistito in Ospedale per un’emorragia interna da quella causa. Alcuni erano morti, per altri era riuscito a tamponare momentaneamente con la sonda a palloncini e con l’iniezione di un liquido trombizzante.
C’erano due macchie nel fegato malato, potevano essere due aree di degenerazione tumorale oppure di rigenerazione epatica.
Per i chirurgi era tumore, per gli altri l’altra cosa: si sarebbe visto all’esame istologico dopo l’intervento. Lui assisteva con apparente indifferenza, era in qualche modo riuscito a gestire l’ansia, il dolore, la disperazione e la speranza. Sì che la bufera dell’anima non appariva all’esterno o cosi lui pensava dall’atteggiamento che gli altri avevano con lui, tanto da chiedergli di esprimere il suo parere sul progetto del trapianto, sulla sua fattibilità, sulla natura di quelle macchie.
Da ultimo era comparso del liquido ascitico in addome e fecero un ulteriore esame per capire se potesse dipendere da un’ostruzione della vena porta. Trovarono che era parzialmente ostruita a causa di un trombo: prescrissero una terapia eparinica. Stava aumentando il numero dei farmaci che doveva assumere, lo costringevano ad alzarsi più volte di notte, gli fecero aumentare il volume delle mammelle. Nella magrezza del corpo facevano contrasto quelle due sporgenze dolenti sotto la camicia, quasi avesse cambiato sesso. Ebbe la tentazione di fuggire, di smettere tutto , ma era subentrata una rassegnazione che prima non avrebbe immaginato di avere.
Forse il coraggio trovato per affrontare quell’ultima battaglia gli permetteva ora di andare avanti o forse l’aveva speso tutto all’inizio, e ora si lasciva trascinare dagli eventi. Continuò con la sensazione di partecipare al gioco infame della roulette russa: ogni giorno la risposta di un esame poteva farlo escludere dalla lista trapianti.
Viveva tutto questo con una coscienza alterata dalla malattia e dallo stato psicologico, una sorta di estraneità, di acquiescenza, che sapeva di training autogeno o di obnubilamento da droghe. Ma se cosi era, erano droghe leggere, perché bastava un niente per ridestarlo e precipitarlo nella consapevolezza del suo stato e di cosa lo aspettava. L’indicazione che avevano dato i chirurgi era stata di percorrere l’iter che avrebbe portato al trapianto, l’epatologo concordava ma era meno assoluto, lasciava allo svolgersi degli accertamenti la conclusione.
Alla fine probabilmente sarebbe stato operato anche per l’insistenza dei colleghi chirurghi che volevano dargli quella chance di sopravvivenza, ma non era certo e il tempo di attesa poteva esser lungo. Gli occorreva di ricordare quando da medico raccomandava ai suoi pazienti con ascite di smettere o per lo meno limitarsi nel bere, perché avevano acqua nella pancia. E quelli rispondevano che la cosa non era possibile, perché in tutta la vita non avevano mai bevuto acqua solo vino.
La beffa per lui astemio, era che aveva avuto in sorte un destino peggiore del loro: la loro malattia era in qualche modo più benigna come di cosa naturale, com’era il vino che l’aveva causata, e spesso bastava moderarsi o smettere , mangiando più abbondante e sano, perché l’organo riprendesse un po’ la sua funzione e li facesse tirare avanti anche a lungo.
Non era il suo caso, per lui la malattia era causata da virus invisibili che lavoravano per anni in silenzio, sino a portare alla distruzione dell’organo, e non c’erano farmaci che potessero ucciderlo, il maledetto.
In quei lunghi mesi di definizione della malattia e poi di attesa, la forza per non soccombere alla disperazione, alla voglia di fuggire , la forza per affrontare responsi amari o definitivi, per continuare quel gioco infernale , ogni giorno un nuovo esame, una nuova possibile complicazione del male… Quella forza dove trovarla?
Si era preparato ad affrontare quel lungo viaggio con gli strumenti della cultura, e quando quelli non bastarono più, andava con il pensiero ai genitori scomparsi, all’amore della consorte. Infine chiese aiuto a Dio e lo trovò in un sogno.
Gli apparve l’immagine di una strada sterrata dove Gesù procedeva con la croce addosso e c’era lui che gli arrancava dietro e scivolava continuamente nella scarpata laterale, da lì allungava una mano e trovava quella di Lui, che senza guardarlo e senza fermarsi, lo trascinava con Sé lungo la strada, salvo dalla forra dove era caduto.
In quella forra lasciava gli esami di laboratorio, le endoscopie, le immagini Tac, Rmn, e tutto quanto raccontava il suo male. Vicino la casa che abitava, in una Chiesa visitata da turista, ricordò di un Cristo in un altare laterale che somigliava straordinariamente a quello del sogno. Prese a frequentarla.
La figura appena sbozzata da un anonimo artista lombardo comunicava una incredibile e drammatica sofferenza, come simbolo di un dolore cosmico. Lo pregava di stargli vicino, di non lasciare la sua mano, di aiutarlo nell’affrontare quella prova. Pregava con pudore, erano parole sommesse, provava una sorta di vergogna a raccomandarsi ora che aveva bisogno, avrebbe dovuto farlo prima. Quanto le parole fossero sincero atto di fede o farisaica devozione per apparire migliore e quindi sperare nell’aiuto divino è difficile dirlo.
Nell’ambulatorio c’erano due infermiere, informali, efficienti. Ti facevano sentire a casa, erano come gente di famiglia, ti chiamavano per nome. Una terza si occupava della gestione amministrativa, aveva un appeal diverso, seducente nel camminare, nel gestire, nel vestire. Tutto il personale in quell’ambulatorio, ognuno nel proprio ruolo, riusciva a mandare avanti con successo l’attività.
Al di fuori dei protocolli, delle linee guida, degli audit, di tutto quello che fa la babele della sanità, si riusciva a dare una risposta ai bisogni della gente, dove tutto sembra disordine, approssimazione, furbizia, noncuranza e sfottò, ma alla fine come per incanto le cose vengono fatte per la meraviglia di tutti. Nell’ambulatorio aveva sede anche una Associazione di trapiantati, ne facevano parte malati storici, operati più di dieci anni addietro, altri con storie più recenti.
Svolgeva un’azione di sostegno ai nuovi arrivi. Rimanevano aggrappati lì, dove erano arrivati disperati, inseguiti dalla morte che si era fermata fuori dell’edificio, ma in agguato. Erano ormai sei mesi da quando era iniziato quel calvario.
Lisa andò in cucina, preparò un brodo e del formaggio e cenarono. Il pasto gli dette un senso di benessere, e sistemata la cucina andarono in salotto, avrebbero visto qualcosa alla televisione, poi sarebbero andati a letto. Prima di accendere la televisione gli vennero in mente le cose che avrebbe dovuto fare la mattina seguente: la banca, la libreria, il conto dal meccanico, l’assicurazione.
Aveva posato il telefonino sul tavolo, lei si era seduta in poltrona, lui si accingeva a farlo. Quando il telefono squillo guardò l’ora, erano quasi le undici chi poteva essere? Non osò darsi una risposta, guardò Lisa, lei si era quasi alzata, spinse il tasto “Pronto…. forse c’è l’organo per te, non ti muovere, ti darò conferma tra un po’”. Lo colse un senso di angosciosa estraneità… Ma era lui che avevano chiamato? E poi subito dopo un grumo informe diventò una domanda chiara e definitiva: “hai capito ora a cosa hai dato il consenso sei mesi fa?” Tra poche ore ti addormenteranno, ti incideranno la pelle con quel taglio devastante a Y che somiglia allo stemma della Mercedes, ti…
Navigò in quei pensieri una frazione di tempo, poi subito fu preso dalle cose da fare per arrivare in tempo in Ospedale, telefonò alla Croce Bianca che in tutti quei mesi aveva tenuto in allerta ogni volta che tornava a casa, risposero che avrebbero organizzato il viaggio, ma lo dissero come se non fosse così scontato, così lui lo percepì. Intanto Lisa aveva preparato la valigia con le sue cose da portare in Ospedale, sedeva in attesa. Lui non riusciva, andò fuori, l’aria era tiepida, non c’era nessuno per la strada, spiava quando sarebbe arrivata l’autoambulanza, l’avrebbe fermata un po’ prima per non farla venire davanti casa, per pudore nei confronti dei vicini.
Sentiva come una vergogna, lui dentro la lettiga di quel coso con le luci intermittenti magari la sirena se avesse incontrato traffico.
“Aveva pensato bene a tutte quelle ore con un tubo in gola e tutti quei cateteri nelle vene, gli avrebbero strappato via quell’organo che dicevano malato. Avrebbero dovuto passare una klemmer tra le vena cava e la faccia posteriore del fegato, passarci una fettuccia. Una manovra rischiosa, condotta alla cieca. Se si fossero sbagliati, se si fosse incontrata qualche aderenza, o una vena accessoria o anomala. Si sarebbe prodotta un’emorragia gravissima difficilmente dominabile, forse non ci sarebbe stato niente da fare. Poi avrebbero dovuto fare tutte quelle anastomosi: la vena porta, l’arteria epatica, le vene sovra epatiche, la via biliare. Sarebbero venute bene, avrebbero mollato o prodotto una stenosi?. Poi tutte le ore dell’intervento, come morto dopo aver tolto il suo fegato, e tornato alla vita se quello trapiantato dava segni di funzionare”.
All’improvviso vide lampeggiare l’autoambulanza, Lisa era comparsa sulla porta, lui parlò in modo disinvolto all’autista e all’accompagnatrice nel salire nel vano posteriore. Lisa insistette perché lui si stendesse sulla lettiga mentre lei sedeva su una panca accanto. Andarono in reparto, due infermiere assonnate gli fecero un prelievo di sangue. Poi si stese sul lettino dell’ambulatorio perché un letto non c’era, Lisa accanto su una sedia. Provava un dolore profondo per lei accanto, coinvolta in quella storia maledetta, non era giusto, per lui ci stava, era nel conto e quel Cristo lombardo aveva aggiunto una giustificazione a quella sofferenza. Ma lei che c’entrava, aveva già sofferto abbastanza del suo prima di conoscerlo, forse quel matrimonio era stato per lei il compiersi di un progetto di vita. Ma poi… Ed ora quella prova, lei seduta accanto, loro due soli, in quella notte decisiva, l’universo intorno indifferente. Un brivido mentale di quelli che a volte lo prendevano da ragazzo, come un’estraneità, una non consapevolezza di sé, gli passò improvviso come una folata di vento, ma aveva un sapore diverso da allora, quasi la tentazione di abbandonarvisi.
Poi venne l’ora di andare, forse un bacio fugace, non lacrime poi di nuovo un senso di estraneità. La barella nell’ascensore e in sala operatoria, non più pensieri, il saluto della ferrista e della caposala, l’avvicinarsi dell’anestesista , il suo scusarsi per la levataccia mattutina che aveva procurato a tutti , non alleggerimento della paura, qualcosa tra buona educazione e una battuta. Poi più nulla…
Dopo un attimo o un tempo indicibile si risvegliò. Non poteva muoversi, un respiratore con un rumore alternante gli pompava aria nei polmoni attraverso un tubo che gli entrava in gola dalla bocca, tubi uscivano dall’addome e la vasta ferita subito sotto l’arcata costale gli procurava un dolore sordo, continuo. Dal collo uscivano cateteri che raggiungevano bocce per le fleboclisi e apparecchiature per il monitoraggio della pressione arteriosa, della pressione venosa centrale, della tensione dei gas nel sangue. Altri fili partivano dal torace e dagli arti per monitorare l’attività cardiaca. Prigioniero in quel letto infame.
Non pensò a Lisa, né ai genitori, non preghiere, non sogni, nessun conforto. Uno stato di sospensione, la smania, un tentativo di preghiera affinchè tutto finisse presto. Tornare a casa a morire o vivere.
Erano passati tre mesi.
A giugno si era dovuto ricoverare di nuovo per un’infezione con febbre alta e insufficienza renale. Ora si era alla fine di luglio, aveva fatto l’ultimo controllo dei parametri ematici. Erano accettabili i valori della funzionalità epatica, un po’ meno quelli renali. Se ne andò al paese della sua infanzia.
Fece le scale dei tre piani, il pianerottolo di ogni piano gli serviva per una sosta, per riprendere fiato. La casa era intatta, come l’aveva lasciata l’anno prima. La grande stanza con il camino e i mobili antichi stile ventennio, impellicciati, radica di noce e palissandro, portati lì da una casa abbandonata di ponte Centesimo, sottratti al fuoco di barbara ignoranza, di vecchiume da eliminare. Le due finestre che davano sulla piazza, di là il tinello con i mobili poveri, in stile spagnolo, della mamma. In fondo la camera con il letto in ferro battuto.
Dalla porta-finestra della stanza da letto andò sul terrazzo interno che dava sui tetti delle case intorno, e da lì, salendo la scaletta di ferro addossata alla parete, salì sul grande terrazzo che si affacciava sulla piazza e da dove lo sguardo poteva vagare senza ostacoli tutto intorno, con il monte che incombeva benigno e la campagna verdeggiante a valle.
Trattenne lacrime di felicità.
Giorno dopo giorno fu un riacquistare le forze, un tornare alla vita. Dopo tanto tornava a dormire, nonostante i rumori della piazza e il campanone che suonava tutti i quarti anche di notte. Era stare molto a casa, un prendersi cura di sé, scendere in piazza dove trovare l’abbraccio della gente che gli si stringeva intorno, chi con discrezione con una vaga allusione alla salute, chi apertamente chiedendo dell’operazione.
Lui rispondeva parco, per pudore, non vergogna e dava segni di gratitudine per l’affetto ricevuto. Alcuni di coloro che gli si avvicinavano lui li aveva operati nel vicino ospedale, altri erano solo conoscenti, pochi i parenti, scomparsi i più. Ma in paese c’erano ancora gli amici di una vita. Era tornato anche Mimmo il compagno d’Università. Erano di nuovo tutti lì, insieme.
Il turbine della vita appariva chetato per loro, chi sa se per sempre. Per intanto le giornate trascorrevano pigre ma felici in casa, seduto sul terrazzo a guardare il sole nel suo meraviglioso viaggio dall’alba al tramonto.
E’ stata una straordinaria miracolosa avventura, sul filo della disperazione e della speranza, dell’ansia, del dolore, della fede, della solidarietà, dell’amicizia, dell’amore. Man mano che tempo il tempo passa qualche ricordo si scolora , qualche altro scompare, ma qualche altro diventa più grande e più vivo. Cresce la sensazione del miracolo, della scienza che mi ha preso per mano e mi ha fatto attraversare lo Stige come fece Virgilio con Dante Alighieri, ma nella opposta direzione. Forse sull’altra riva è rimasta l’ombra di quello che ero, un fantasma disperato. E quell’ombra nella mia memoria tende a scomparire sostituita dalla vita ritornata nella sua pienezza, nel desiderio di esserci, nella voglia di restarci. E’ difficile per chi non è mai entrato in quel tunnel, comprendere la bellezza della luce ritrovata all’uscita ed il desiderio di dividere con gratitudine e fede quella felicità con quelli che il miracolo hanno fatto con la competenza e con l’amore.