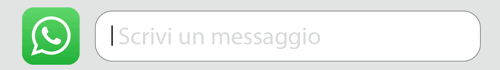Parlare di me stesso, delle mie vicende personali, lo ritengo da sempre del tutto insignificante. Questa volta sono costretto a soprassedere soprattutto per l’interesse generale o la curiosità di sapere da un diretto interessato cosa si prova quando ci si ammala di Covid, quali sensazioni si hanno, quali attese circa il proprio imminente futuro, infine che ci si aspetta una volta che sarà varcata la soglia del ritorno alla vita.
Nel fare la cronaca, è corretto partire dalla notizia che ha generato l’avvenimento che si racconta. Ecco dunque quel che mi è accaduto.
Avevo trascorso il periodo natalizio in tranquillità e in buona salute, così l’avvertivo, compatibilmente con la mia età che, il prossimo mese di luglio, mi porterà a varcare la soglia degli 85 anni. Come nei lunghi mesi precedenti, avevo seguito tutte le raccomandazioni per scansare la pandemia, con il mio spirito libertario che mi porta a rifuggire dai luoghi comuni, dalle voghe, dai tam tam ripetuti del detto e del sentito dire. In certo senso, mi ero vaccinato contro le esternazioni di virologhi e scienziati – tutti professionalmente onesti e ammirevoli per la loro responsabilità nei confronti della comunità nazionale e della salute dei singoli cittadini.
Per chi come me ha impresso nella memoria il ricordo vissuto dell’ultima guerra, i sacrifici dolorosi ( dei genitori e dei nonni), i bombardamenti, l’occupazione nazista, gli eccidi e le distruzioni che allora dovemmo attraversare, uscire di casa con un fazzoletto a tappare naso e bocca, fare la fila al supermercato, era quasi un rivivere, in maniera semiseria, alcuni momenti dell’infanzia. Tornare ragazzini è un sogno esilarante che, lo confesso, in alcuni attimi della primavera 2020, avevo vissuto.
Se siamo usciti a quella tragedia e ricostruito un’Italia libera e più forte, pensavo e raccontavo a chi mi era intorno, cosa vogliamo che sia questa pandemia. Sbagliavo di grosso.
Quando il virus è arrivato, non me ne sono accorto. Un tantino di debolezza, qualche tremore di freddo verso sera, ma niente di più e, quindi, nessun allarme. Poi ho fatto u n tampone naso-faringeo e si è scoperto che avevo contratto il covid.
Era entrato il nuovo anno, mi rammaricavo di non aver trascorso qualche giornata festiva con i miei nipoti, ma anche questo non era poi la fine. Sabato 9 gennaio al mattino non stavo in piedi. L’ambulanza chiamata, a mia insaputa, da mio figlio, era arrivata. Gli addetti mi hanno invitato a seguirli e così, vestito alla bella e meglio, sono arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Gemelli di Roma.
Primi accertamenti, analisi varie e trasferimento presso il reparto covid attrezzato nella dependance ospedaliera Columbus. Sistemato in una stanza, da solo, e sottoposto ad una terapia intensiva, ossigeno, redavir, cortisone e altro che appartiene alla scienza medica e suo quale, come insegna Dante, “più non dimandare”. Sono rimasto in cura al Gemelli tre settimane, poi un’altra settimana all’IDI, finché sono risultato prima negativo al virus, poi dichiarato guarito e dimesso martedì 2 febbraio.
Ho il dovere morale e l’obbligo civile di rendere testimonianza sull’efficienza – riscontrata – della sanità pubblica, sull’abnegazione dei medici e di tutto il personale sanitario.
Quando ho saputo che il ricovero di un malato di covid ha un costo giornaliero di circa 1.000 euro, ho convenuto che lo Stato non è poi così patrigno come troppo spesso si usa sostenere.
Prima di passare al dopo, debbo fare un’osservazione importante riguardante le strutture dei reparti dove sono stato ricoverato. Ho tratto l’impressione che fossero reparti riaperti per l’occasione della pandemia, in modo da avere posti sufficienti ad accogliere e curare i malati. Al riguardo sarebbe utile, o meglio indispensabile, che a livello di spesa nazionale si facesse una riflessione sullo stato delle cose: strutture, mezzi tecnici e sanitari e, non da ultimo, una rivalutazione della retribuzioni alle categorie di professionisti ai quali è affidata e dipende la vita di decine di migliaia di italiani. Io, che ho vissuto questa esperienza, me ne sono reso pienamente conto e, qui, ne rendo testimonianza.
Vengo alle sensazioni personali come mi ha chiesto di raccontare il prof. Eugenio Santoro.
Debbo anticipare un fatto. Leggendo i referti del Gemelli e dell’IDI, una volta tornato a casa, mi sono reso conto che per un buon tratto della mia degenza sono stato in pericolo di vita, per dirla francamente più di là che di qua. Mio figlio, che si manteneva in contatto con i medici, non me ne aveva mai accennato , ma chiedeva con insistenza “come ti senti?” E come mi sento – rispondevo – non c’è male”.
Senza accorgermene, stavo veramente messo male, ma ero sereno. All’inizio pensavo che la faccenda si potesse sbrigare in pochi giorni. Poi, notando l’insistenza dei sanitari attorno a me, specie quando si meravigliavano che potessi alzarmi dal letto per spicciare le mie faccende personali, mi è venuto il sospetto che le cose non andassero troppo bene.
Ma che vuoi, mi dicevo, in più di ottanta anni traversie ne hai avute molte, l’hai sempre scampata e forse questa non sarà l’ultima.
Quel forse mi richiamava alla memoria la frase che mi disse il poeta Giuseppe Ungaretti la mattina di un lontano giorno di febbraio del 1968 mentre attraversavamo Piazza del Parlamento, lui diretto al Caffè Aragno, al tempo abituale ritrovo di artisti e letterati, io alla sede della Comit ove allora lavoravo. Era caduto un filo di neve, si scivolava. Avevo preso il maestro sottobraccio per evitare cadesse, così parlando gli feci gli auguri per gli ottanta anni che aveva compiuto. Eh, caro, mi rispose, “ho chiuso il quarto ventennio”, per dire che d’animo e d’intelletto, chi vuole, non invecchia mai.
Quel ricordo mi rese sereno e mi aiutò non poco a sentirmi meglio dell’abituale non c’è male. Mentre i giorni passavano , mi si affacciò alla mente un’idea che a raccontarla fa sorridere. Gianfrà – dicevo a me stesso – stai passando un periodo di tranquilla vacanza, senza pensieri, senza la necessità di assolvere impegni, goditela!
Per qualche ora me la sono goduta. Finché un mattino il tg delle 8 ha dato la notizia della scomparsa di Emanuele Macaluso, da qualche tempo ricoverato anche lui al Gemelli. Non mi sono allarmato, piuttosto dispiaciuto assai. Con Emanuele ero da tanti anni in rapporto amichevole, da quando Rino Formica mi aveva messo in contatto con lui al tempo dell’Unità socialista (fine anni ’80), che non si riuscì mai a realizzare, e poi con la fondazione della rivista Le ragioni del socialismo. Veniva a mancare un punto fermo nella storia della sinistra italiana, e non vale che Emanuele avesse compiuto 95 anni poche settimane prima, mi rattristò il fatto che spariva una voce libera e critica contro il decadimento della politica italiana.
Per una volta ancora feci la costatazione che la vita, prima o poi, presenta il conto a tutti, ai personaggi e alle persone umili. Di conseguenza non restava che guardare avanti. Così feci, con la sensazione che c’è sempre da non demordere, da riflettere sul presente e sue quello che può accadere, perché come ammoniva Pietro Nenni, “quando tutto sembra finito c’è tutto da ricominciare”.
Ed io, intanto, continuavo a vivere con il conforto dei miei famigliari, dei miei amatissimi nipoti che spesso mi chiamavano al telefono. Ho davvero apprezzato quel marchingegno rappresentato dal cellulare che ti mette in contatto con gli altri in qualunque parte del mondo ci si trovi l’un l’altro. E, mi sono vergognato di essere rimasto, in proposito, vicino all’età della pietra.
Le visite erano interdette e neanche si poteva uscire dalla propria stanza. Ho provato e provo disappunto verso coloro che parlano della solitudine dei ricoverati privati delle visite. Chi lamenta questa situazione non si rende conto della gravità a cui si andrebbe contro in caso contrario, e di quale sarebbe il rischio personale dei visitatori e i rischi conseguenti per il personale sanitario.
Ho paragonato l’epidemia in corso ad una guerra, che sta mietendo vittime in massa, a livello mondiale più delle due guerre mondiali singolarmente considerate. I fanti in trincea, i morti nei deserti dell’Africa, i morti e i dispersi nella disperata ritirata di Russia, non hanno avuto il conforto dei loro cari e solo i più fortunati (non suoni come una bestemmia) hanno goduto delle visite nei cimiteri di guerra.
Avverto di essere cinico, ma – nel rispetto di tutti – ritengo sia necessario avere cognizione della realtà e, pur nel dolore più atroce, badare tutti alla vita degli altri.
Nel contesto in cui sto passando queste giornate di ritorno alla vita, ho ripreso a pensare come sempre, anzi non ho smesso mai di farlo, vale a dire guardare innanzi, pensare più a chi ti sta intorno e ti sta a cuore più a che te stesso. Ciò non significa essere eroi né vocati al martirio, semplicemente avere una visione della vita che trascorre e mai torna indietro, che bisogna prenderla come viene, che domani è un altro giorno e va vissuto con gli stessi sentimenti e le stesse passioni che ci portiamo dentro. Il futuro sarà quel che Dio vorrà.
Ecco, il Dio, cos’è per un laico, cosa rappresenta, quali pensieri lo conducono a Lui. Qui, veramente, sono in grande difficoltà. Gli insegnamenti avuti da bambino sono non del tutto dimenticati, ma sepolti sotto la polvere di decenni e decenni di non pratica. E’ vero che nel momento del pericolo si fa, tal volta, ricorso ad un’entità misteriosa, che venga in soccorso. Non a caso, ricordo come le chiese fossero piene durante l’occupazione nazista e le processioni dei fedeli delle parrocchie romane a pregare l’immagine della Madonna del Divino Amore che era stata trasferita nella chiesa di piazza S. Ignazio.
Passata la festa, gabbato il santo, sentenzia un antico detto popolare. Così è stato per milioni di italiani.
Al di là delle poche nozioni che possiedo sull’Universo, la sua origine e il suo andamento, oltre l’agnosticismo sull’ esistenza e la collocazione di quell’ Entità e di ciò che segue nella pratica religiosa, mi resta personalmente l’insegnamento per il rispetto del prossimo, per la salvaguardia di ciò che ci circonda, per l’interesse della comunità umana di cui faccio parte, con tutti difetti e le enormi deficienze che mi contraddistinguono.
Ciò detto, ho poco da attendermi una volta varcata la soglia del non ritorno. Coltivo solo la speranza di non essere disprezzato per quel che ho fatto e per come ho trascorso la vita. Di più,credo, sia difficile attendersi epretendere.
Ho vissuto questa umana vicenda in maniera serena, senza ambasce e senza attese particolari. Ne sono venuto fuori in piedi, magari un poco acciaccato, ma (spero) con la mente lucida. Questo mi porta a concludere che la sorte è stata dalla mia parte. Questa sorte ha un nome preciso e fermo, il nome dei professori, dei giovani medici, dei sanitari, donne e uomini che mi hannoavuto in cura, nei cui confronti non ho parole adatte e sufficienti per esprimere la mia gratitudine e il mio rispetto.
La sorte è una componente della vita, con me è stata benigna tanto che posso rivolgere un pensiero a quei compagni, giusto della mia età, che a causa della stessa pandemia non ce l’hanno fatta, e pochi giorni or sono ci hanno lasciato: Pietro Larizza (ex segretario della Uil, parlamentare e presidente del CNEL) e Carlo Tognoli (ex sindaco di Milano, parlamentare e ministro) con i quali ho condiviso significative e indimenticabili vicende politiche, tra i tempi più appassionanti e belli della mia vita.