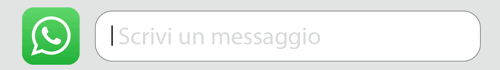A parte l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche il grosso della Missione 6 sulla Sanità del Pnrr riguarda il rafforzamento della rete territoriale delle aziende sanitarie.
Le direzioni di marcia sono due: Case di comunità e Assistenza domiciliare (con 602 Centri operativi territoriali, 1208 Case di comunità e a livello intermedio 381 Ospedali di comunità)
A proposito di Case di comunità non esiste da nessuna parte una definizione chiara che spieghi senza ambiguità cosa voglia dire per questi servizi il termine “comunità”. A tutta prima sembrerebbe una operazione puramente nominalistica cioè l’uso di un nome nuovo per chiamare delle cose vecchie come infatti sono oggi le “case della salute” che a loro volta altro non sono se non la riedizione dei poliambulatori Inam di circa un secolo fa. A giudicare dalle funzioni descritte nel Pnrr effettivamente sembrerebbe così.
Ma se così fosse non sembra adeguato, ed è quanto meno discutibile, rispondere ad una pandemia resuscitando vecchi modelli di servizio del passato, corrispondenti a concezioni di welfare ormai ampiamente superate e riformate. Resta da capire, a parte darci l’illusione di un finto cambiamento, la ragione pratica di questa operazione ingannevole cioè il perché nel riproporre la vecchia idea di poliambulatorio scomodare il concetto comunità.
La risposta ai nostri dubbi ci viene da coloro che hanno avuto l’idea della casa di comunità (Prima la comunità) che contestando la lettura banale che interpreta la casa di comunità come un poliambulatorio cioè un ex casa della salute ci spiegano che in realtà essa si chiama di comunità perché è una idea di servizio pubblico, ma con una nuova forma di gestione sociale.
Questa interpretazione a ben vedere non è altro che la traduzione dell’idea di welfare dal basso su cui tanto si è discusso in questi anni cioè di un welfare che non viene più gestito direttamente dall’Azienda pubblica, ma viene gestito o co-gestito soprattutto da chi ritiene di rappresentare la comunità, in particolare il Terzo settore.
Da molti anni ormai sostengo che la gestione aziendale della sanità è una tragedia perché è una gestione ottusamente monocratica e che bisogna pensare ad una gestione nuova a partecipazione sociale, ma essendo un convinto difensore della sanità pubblica, personalmente, al Terzo settore preferisco i Consorzi o, ripuliti per bene, i vecchi Comitati di gestione di una volta nominati dai Comuni. Cioè nuove forme di gestione pubblica partecipata. Chiedo ai rappresentanti di “Prima la Comunità”, perché se la partecipazione della Comunità in sanità è tanto importante, limitarla ai soli ambulatori e non estenderla a tutto il sistema sanitario, cioè a tutti i servizi, ospedali compresi? Cioè perché non rinnovare l’intero sistema sanitario superando le aziende con altre forme di gestione?
Gli Ospedali di comunità ai fini della gestione partecipata valgono come le Case di comunità? Se si, allora in ragione di quale logica si escludono gli altri Ospedali dal beneficio sociale della partecipazione? Personalmente avrei forti perplessità nei confronti di una operazione che alla fine, senza cambiare la gestione aziendale, si limitasse ad appaltare parti del sistema sanitario pubblico al Terzo settore.
Ma in tutto ciò emergono due enormi questioni politiche. Riformare la gestione di un qualsiasi servizio sanitario pubblico non è uno scherzo. La casa di comunità funziona grazie ad una comunità di professioni ed è questa comunità che manda avanti un intero sistema di servizi: quale ruolo ha questa comunità nella gestione? Si può decidere di cambiare senza sentire chi lavora?
Dal momento che nel Pnrr manca una definizione di Casa di comunità resta aperta la questione, tutta politica, di connotarla. Bisognerebbe chiedere al Ministro Speranza: se le Case di comunità sono solo Poliambulatori gestiti dalla Azienda o se sono, come dice don Virginio Colmegna il Presidente di “Prima la Comunità”, strumenti per “una rifondazione del sistema di welfare “.
In quest’ultimo caso, non saremmo di fronte a una riforma, per il semplice motivo che la missione 6 non sarebbe una riforma, ma una contro-riforma. Per giunta fatta senza dirlo, senza aprire una discussione, senza giocare a carte scoperte, allo scopo di dare parte dei 20 mld del Recovery plan al Terzo settore.
Per quanto riguarda invece l’assistenza domiciliare il discorso è diverso. L’assistenza domiciliare, dice la Missione 6, «si rivolge in particolare ai pazienti di età superiore ai 65 anni con una o più patologie croniche e/o non autosufficienti». L’obiettivo è «aumentare il volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico, entro la metà del 2026, il 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni».
Per questo progetto si prevedono 4 miliardi di Euro, di cui 2,72 miliardi connessi ai costi derivanti dal servire un numero crescente di pazienti; 0,28 miliardi per l’istituzione delle centrali operative territoriali (Cot), 1 miliardo per la telemedicina. Sugli obiettivi nessun problema ma sui modi di raggiungerli molte sono le sorprese.
Il Pnrr dice infatti che per raggiungere tali obiettivi si utilizzeranno gli «strumenti della programmazione negoziata», cioè il Ministro rinuncia alla gestione diretta dell’assistenza domiciliare da parte delle aziende pubbliche per appaltarla di fatto ai famosi Enti gestori, cioè al Terzo settore e al privato. Non è quindi un caso se la proposta non prevede una sola assunzione da parte del pubblico.
Rammento che per sviluppare una vera assistenza domiciliare pubblica servirebbero: un certo numeri di infermieri, un ripensamento dei ruoli professionali, nuovi modelli organizzativi, ma soprattutto la rinegoziazione dei tetti di spesa del personale previsti con il famoso «decreto Calabria». Nulla di tutto ciò però è compreso nel Pnrr. Sembra perciò che la logica del Governo sull’assistenza domiciliare sia quella di mercato, una logica molto lombarda: il pubblico acquista dal privato prestazioni assistenziali sulla base di tariffe concordate
In sostanza, mentre nel discorso politico-mediatico si sostiene la sanità pubblica e universale, nella realtà si compra l’assistenza territoriale (case di comunità, assistenza residenziale e assistenza domiciliare) dal Terzo settore e dal privato. La risposta alla pandemia è dunque la privatizzazione (finanziata dallo stato con il Recovery plan) dell’assistenza agli anziani, vale a dire, nel nostro tempo, il vero soggetto politico emergente della sanità e il soggetto più colpito direttamente dalla pandemia. Una logica peraltro coerente visto che, l’8 settembre 2020 il ministro Speranza con un decreto istituì la Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana, assegnandone la presidenza a monsignor Paglia (Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico per le scienze del matrimonio e della famiglia). Come mettere la capra a guardia dell’orto.
In quell’occasione, il Ministro dichiarava che «i mesi del Covid hanno fatto emergere la necessità di un profondo ripensamento delle politiche di assistenza sociosanitaria per la popolazione più anziana. La commissione aiuterà le Istituzioni ad indagare il fenomeno e a proporre le necessarie ipotesi di riforma».(QS 21 settembre 2020). C’è da presumere quindi che le scelte del Pnrr sull’assistenza territoriale e in particolare sull’assistenza domiciliare siano state suggerite dalla Commissione Paglia.
Anziché indurre il Governo a ridiscutere il monopolio del Terzo Settore e del privato sull’assistenza agli anziani, la pandemia ha suggerito non solo di formalizzare tale monopolio, ma anche di estenderlo e di rafforzarlo fino a renderlo esclusivo. Un’abdicazione dello Stato ai suoi doveri. Insomma l’idea di Speranza di assistenza territoriale sembra consistere nella riduzione dello spazio assistenziale del pubblico e con un ampiamento di quello del Terzo settore e del privato.
Ho forti dubbi che dopo una pandemia con più di 120000 morti, la maggior parte anziani, questa sia una buona soluzione.